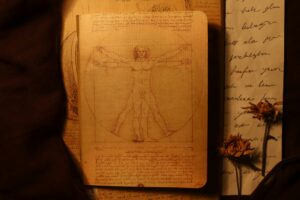Pochi sanno che Leonardo da Vinci è stato il capo cuoco di una taverna a Firenze e che, probabilmente, è stato il primo gourmet della storia della cucina. Stupiti? Eppure è proprio così e la storia è affascinante e persino divertente. Infatti, nel 1473, a causa della morte dei cuochi della Taverna delle Tre Lumache, misteriosamente avvelenati, nella quale lavorava come cameriere, la proprietà lo trasforma in cuoco. Ma lui, da grande inventore e artista, pensa immediatamente di innovare la cucina di quel luogo, che gli appare grezza e disgustosa.
Non sopporta quegli enormi quantitativi di polenta servita con carni stoppose che è il “signature dish” del locale e ritiene di passare ad una cucina più raffinata, fatta di piccole porzioni, di impiattamenti eleganti e di forme ottenute intagliando verdure e ortaggi. Una sorta di nouvelle cuisine che lui sentiva di dover spingere in funzione della sensazione dell’arrivo di quel Rinascimento che la sua superiore intelligenza e cultura probabilmente stavano già fiutando. Ma i clienti del locale che si videro arrivare a tavola delle piccole fette di pane con alcune foglie di basilico tenute insieme con della saliva di vitello, non compresero questa innovazione. Loro andavano in taverna per mangiare e bere in abbondanza e le proteste arrivarono a costringere Leonardo a rinunciare all’incarico, temendo persino per la sua vita.
Continua, così, a dedicarsi alla pittura e ai suoi progetti che, in buona parte, erano finalizzati alla realizzazione di macchine per agevolare il lavoro in cucina, finché, alcuni anni dopo, la taverna prese fuoco. In sostituzione delle Tre Lumache, insieme al suo amico artista Alessandro, figlio di Mariano di Vanni Filipepi e di Smeralda Filipepi, conosciuto come Sandro Botticelli, Leonardo crea una locanda nella quale ripropone le sue idee innovative. I due artisti la chiamano “Le Tre Rane di Sandro e Leonardo” e ne dipingono personalmente due belle insegne all’ingresso, ma anche questa nuova iniziativa fallisce miseramente. La nobiltà fiorentina non apprezza le misere proposte di piatti agghindati ad arte e ben presto sono costretti a chiudere.
A questo punto, Leonardo prova a farsi assumere come cuoco in altri luoghi ma, ormai, la sua fama negativa si è diffusa al punto che tutti lo tenevano alla larga, così non trova lavoro per i successivi tre anni, durante i quali, però, invia modellini di marzapane al principe Lorenzo de’ Medici, che pur non apprezzando più di tanto tali regali, usava offrirli ai suoi ospiti nelle cene di corte. Leonardo, stanco e avvilito da tanta incomprensione, medita di andar via da Firenze e il principe, quasi per scusarsi, invia una lettera di presentazione a Ludovico Sforza, duca di Milano.
Nella lettera lo raccomanda quale bravo suonatore di liuto e null’altro, senza riferimento né alle sue capacità artistiche né alla sua bravura di cuoco, di cui Leonardo è fermamente convinto al punto di sostenere, in una sua ulteriore lettera di presentazione che porta con sé a Milano, di non avere rivali oltre che nella pittura, nella scultura e nell’inventare ponti, fortificazioni e catapulte, anche nel preparare torte.
Ludovico Sforza, detto il Moro, nonostante abbia una buona dose di scetticismo, lo accoglie e gli conferisce l’incarico di consigliere e gran maestro di feste e banchetti di corte. Dopo alcuni mesi passati, però, a suonare il liuto e dipingere ritratti delle donne di corte, arriva la sua occasione. Ludovico gli chiede di organizzare un banchetto per una sua nipote e così il testardo artista torna a pensare a quei piatti che non erano stati compresi a Firenze e gli propone un menu che contiene:
un involtino d’acciuga in cima a una rondella di rapa scolpita a mò di rana
un’acciuga avvolta intorno a un broccolo
una carota finemente intagliata
un cuore di carciofo
due mezzi cetrioli su una foglia di lattuga
un petto d’uccello
un uovo di pavoncella
un testicolo di pecora con panna
una zampa di rana su una foglia di tarassaco
uno stinco di pecora cotto, con l’osso.
Ludovico, basito, gli dice che non possono essere quelli i piatti da servire agli importanti ospiti degli Sforza, pertanto gli ordinò di preparare tutt’altro, tra salsicce, stinchi, zamponi, pavoni, vitelli interi, maccheroni, ostriche, storione e tartufi. Ma Ludovico, pur bocciando la sua idea di cucina, decide di sfruttare la capacità inventiva di Leonardo e gli affida l’incarico di ristrutturare le cucine del Palazzo.
E così, finalmente, Leonardo può quantomeno sbizzarrirsi nel creare, tra le tante cose, nastri trasportatori per la legna, un arrostitore automatico per evitare di avere una persona esclusivamente addetta a rigirare lo spiedo, uno scaldaacqua a carbone, una spazzola rotante per tenere pulito il pavimento, macchine per lavare e tritare, un affettapane a vento e una macchina formata da tanti soffietti per scacciare i cattivi odori.
Tutti macchinari che non sempre funzionano alla perfezione e che fanno esclamare all’ambasciatore di Firenze alla corte degli Sforza che quella cucina è una vera bolgia. Quel disastro convince Ludovico che Leonardo deve esser allontanato e gli offre un po’ di riposo in campagna. Dopo qualche tempo torna a progettare le scenografie per il matrimonio tra Ludovico e Beatrice d’Este, creando un enorme palazzo alto duecento piedi formato da torte accatastate, ma non prevede che, messe nel cortile dal giorno precedente, sarebbero state oggetto di attacco da parte di uccelli e topi.
Dopo questo ulteriore insuccesso si dedica a dipingere la parete del priorato di Santa Maria delle Grazie. Quel dipinto sarà la celeberrima Ultima Cena e sarà proprio questo l’addio di Leonardo alla sua passione per la cucina e per il cibo, una specie di ultimo omaggio. La sua storia di artista continuerà, infatti, dai Borgia, poi ancora a Firenze e nuovamente a Milano, anche se la sua inventiva lo porta persino alla realizzazione degli spaghetti. Ma questa è un’altra storia di cui magari parlerò in un altro articolo. Resta il fatto che, oltre 600 anni fa, lui aveva già intuito, pur in tempi non ancora maturi, che la cucina avrebbe preso una diversa direzione e chissà, se fosse vissuto ai tempi nostri, magari sarebbe diventato un influencer, un creatore di contenuti o un tiktoker!
Riferimenti bibliografici:
Note di cucina di Leonardo da Vinci
autori: Shelagh e Jonathan Routh
editore: Voland